Se chiudo gli occhi e provo ad andare indietro nel tempo, mi sembra di scorgere Vincenzo Valente alle prese con i suoi libri e i suoi dizionari, intento a sfogliare e maneggiare con cura quelli che chiamava i «ferri del mestiere», vocabolari come il Du Cange, cioè il Glossarium mediae et infimae latinitatis, o il Meyer-Lübke, vale a dire il Romanisches etymologisches Wörterbuch. Era il suo modo di inoltrarsi nel lungo cammino della sapienza, per tentare dantescamente di alzare lo sguardo «per tempo al pan de li angeli».
Se chiudo gli occhi e provo ad andare ancora più indietro nel tempo, mi pare di vedere Vincenzo Valente nella penombra del suo studio e di sentire ancora l’incipit di un antico carme. «Cui dono lepidum novum libellum?» mi chiese il professore sfogliando con gioia l’opuscolo che gli avevo appena donato, dopo che ci fummo accomodati uno di fronte all’altro alla sua scrivania. Avrei voluto rispondergli: «Valens, tibi», storpiando il verso catulliano, ma non potendo dargli del tu, dissi semplicemente: «A voi».
Lo ricordo ancora così, mentre salutava con garbo la pubblicazione fresca di stampa ed elogiava la nitidezza dei caratteri tipografici di Angelo Alfonso Mezzina. Era il 1979. Il libretto che gli avevo portato s’intitolava Il canto dell’Ascensione e una ninna-nanna molfettese e si fregiava di una sua presentazione.

Vincenzo Valente si era offerto di scriverla ancor prima che gliela chiedessimo. Dico chiedessimo, perché in quell’opuscolo c’era anche il lavoro di registrazione sul campo di alcuni miei amici, tra i quali figurava sua figlia Teresa Valente, chitarrista e melodiosa cantante del Gruppo per le tradizioni popolari molfettesi “La Berzeffa”. Un nome bizzarro per un impegno preso molto sul serio. Era tempo di folk revival, di utopie giovanili e di accurate ricerche etnografiche. Da quel giorno fu naturale incontrarmi ogni tanto con lui, parlare dei nostri studi e fare progetti per lavori in comune.
In realtà uno dei nostri primi incontri era avvenuto già nel 1974, quando gli avevo portato alcune centinaia di schede di vocaboli molfettesi inediti, per i quali rivelò molto interesse.

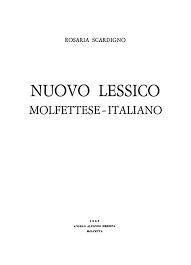
Fu lui a incrementare in me la stima riconoscente per Rosaria Scardigno, autrice di due edizioni di un assai prezioso vocabolario dialettale molfettese. Nel 1957 era uscito il Lessico dialettale bitontino di Giacomo Saracino, arricchito dalle note etimologiche di Vincenzo Valente. Prima che la Scardigno pubblicasse la seconda edizione del dizionario, il professore le propose di aggiungere per ogni lemma le annotazioni degli etimi, in modo da offrire agli studiosi un lavoro più completo. Donna Rosaria si mostrò interessata alla cosa e Valente le portò un congruo numero di etimologie come saggio delle sue integrazioni. La Scardigno lesse, lodò il lavoro, ma alla fine sentenziò: «Troppo latino, professore».
Vincenzo Valente non se ne adontò, perché aveva capito le ragioni intime di quel rifiuto: la studiosa non voleva infarcire di erudizione specialistica la sua opera già così corposa, ma, senza rinunciare alla precisione semantica nella traduzione dei vocaboli, desiderava andare incontro a un pubblico più largo. Valente avrebbe poi riversato nel 1999 questo tesoro etimologico nel vocabolario terlizzese di Francesco Tempesta, suo ex allievo al Liceo di Molfetta.
Gli alunni che lo avevano avuto come docente al Liceo classico, all’Istituto Tecnico Commerciale e all’Istituto Magistrale di Molfetta esaltavano stupefatti la sua prodigiosa memoria e la sua profonda conoscenza della Divina commedia. Quando spiegava Dante, recitava a menadito un gruppo di terzine e poi commentava ogni verso con grande cura, senza mai aprire alcun testo. Questo chiarisce la sua presenza tra i più accreditati dantisti italiani, con la redazione di circa 400 voci in cinque dei sei volumi dell’Enciclopedia dantesca varata dall’Istituto Treccani fra il 1970 e il 1978, che resta una delle sue benemerenze più alte.
Dopo le glosse etimologiche al lessico di Saracino, Valente si lanciò con successo nella critica letteraria. Nel 1958 sul «Ponte» di Enriquez Agnoletti e Tumiati uscì un suo bel saggio su Quasimodo, che gli valse gli elogi dello stesso poeta. Ma dopo altre valide prove il professore – come ebbe poi a spiegarmi – ai «troppo opinabili» esiti della critica letteraria, preferì la scienza più rigorosa della dialettologia e della filologia. Vennero allora alla luce la monografia Puglia sui dialetti dell’area barese e foggiana (1975), le Osservazioni sopra alcuni etimi di voci meridionali (1978 e 1985), il contributo Per una migliore intelligenza del napoletano di G. Basile (1979), il profilo dei Dialetti della Basilicata e della Calabria (1980) e tanti altri scritti. Per questi lavori l’Accademia dei Lincei nel 1981 gli conferì il Premio del Ministero per i beni culturali e ambientali per la Filologia e Linguistica del mondo moderno.
Geloso della sua sfera privata, era poco incline alle confidenze, agli sfoghi e all’effusione dei sentimenti. Eppure, dietro quella misurata riservatezza, si celava un’attenzione paterna inconfessata. Sognava per me traguardi professionali più ambiziosi, ma io gli rispondevo che era un po’ troppo tardi per ricominciare, con la famiglia a carico. Avendo saputo della mia attività pubblicistica per diversi quotidiani italiani e svizzeri o avendo letto con affettuosa attenzione qualche mio lavoro storico o critico, mi incitava a restringere il mio impegno, per economia di lavoro, ai soli campi linguistico e demologico, ma io gli replicavo che quel po’ o quel tanto di giornalismo aveva un suo tornaconto e molte pagine della storia di Molfetta o non erano state ancora scritte o erano piene di errori e che del resto mi riusciva difficile negare il mio apporto agli amici del Centro Studi Molfettesi, della rivista letteraria «La Vallisa» o dell’Archivio Diocesano di Molfetta (con i quali finì anch’egli per collaborare). Allora correggeva il tiro: «Lo so che la tua non è dispersione, lo so che è versatilità e ricchezza d’interessi», ma un momento dopo ammoniva: «Ars longa, vita brevis». E io di rimando una volta, con un filo di tristezza: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas». Quel giorno non volle avere l’ultima parola. Intuì il mio turbamento e aggiunse soltanto: «Hai ragione, hai perfettamente ragione». Tuttavia fu molto felice quando nel 1986 gli dedicai, insieme a mia moglie e mio figlio, un saggio linguistico sui Toponimi prediali degli agri romani di Ruvo e Bitonto.
Pur permanendo nella sua giusta opinione sulla necessità della specializzazione, non mancò di apprezzare i miei lavori critici e storici più impegnativi. Anzi fu proprio lui a insistere perché raccogliessi in un articolo per l’«Archivio Storico Pugliese» le notizie inedite che avevo spigolato sulla chiesa benedettina di San Giacomo di Molfetta. Peraltro non mancava della versatilità che aveva voluto trovare in me: anche lui coltivava la musa poetica, sia pure a latere e sia pure in vernacolo. Mi riferisco in particolare ai versi satirici della serie A Mlëfèttë stimmë a póstë (A Molfetta stiamo a posto) e alle sue ultimissime cose.
Nel ferragosto del 1983 morì a 57 anni, per un male incurabile, la sua prima moglie, Grazia Cascarano, una poetessa e narratrice di sicuro talento, su cui purtroppo è sceso il velo del silenzio. Il colpo fu veramente tremendo per lui, ma il professore contenne il suo dolore con estrema dignità, anche se i suoi studi da solo, con me o con altri amici subirono un’improvvisa battuta d’arresto. Avevamo avviato da una quindicina d’anni un ponderoso lavoro sulla Flora popolare pugliese e sul Lessico botanico molfettese. Valente si offrì per la parte etimologica, mentre a me spettavano lo spoglio bibliografico, l’inchiesta sul campo, l’indagine storica ed etnografica e la corretta identificazione delle piante. Avevamo stretto accordi anche per un nutrito complemento al lessico della Scardigno, che ciascuno aveva iniziato per proprio conto già molto tempo prima. I nostri incontri, che nel periodo più fervido si svolgevano ogni settimana per il controllo della schedatura, si diradarono notevolmente e i tre lavori, il primo a buon punto, il secondo quasi ultimato e il terzo appena cominciato, rimasero incompiuti. Ora centinaia e centinaia di schede di quella immane fatica giacciono nel suo studio di via Rattazzi o chissà dove.
Per fortuna un altro progetto a cui teneva molto, la “Collana di arti e mestieri tradizionali pugliesi”, andò in porto e nel 1985 il Centro Studi Molfettesi per i tipi di Mezzina pubblicò un “quaderno” su U mèstë parèëtë – Il parietaro, cioè sul costruttore di muri a secco e capanni di pietra. Valente desiderava continuare con nuovi saggi sul cordaio e altri mestieri, ma gl’impegni presi via via con le riviste «Lingua nostra», «Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo», «L’Italia dialettale», e ancora con l’Atlante Linguistico dei Laghi Italiani, per il quale chiese e ottenne da me un contributo al 3° Convegno dell’ALLI nel 1991, nonché i rapporti col prof. Giovanni Moretti dell’Università di Perugia, col prof. Luigi Sada di Bari o da ultimo col senatore Beniamino Finocchiaro ritardarono di molto il suo contributo etimologico per il secondo numero della collana. Finalmente nel 1997, dopo molti rinvii, uscì anche il “quaderno” su U fëschëlarë – Il funaio.
Nel frattempo, cinque anni prima, il Centro Studi Molfettesi gli aveva preparato a sua insaputa una miscellanea in suo onore, Molfetta: spicchi di storia, una sorpresa che lo studioso apprezzò molto nel silenzio sconfortante di una città troppo spesso distratta verso i suoi figli migliori e del quale, del resto, non si era mai esplicitamente lamentato.
Benché fosse personalmente schivo e molto selettivo sulle priorità di lavoro, Valente si spendeva nondimeno generosamente in prefazioni, recensioni e presentazioni di libri, conferenze e convegni di studi. Alcuni lo riconoscono ancor oggi come maestro di indagini severe, molti ne ricordano le doti di conferenziere acuto e coinvolgente, tutti gli riconoscevano una cultura e un ingegno davvero fuori dell’ordinario.
La rivista comunale «Studi molfettesi», da me diretta, si è chiusa degnamente con un suo significativo contributo sul rapporto tra suo zio Adelchi Valente e Gaetano Salvemini. Intellettuale attento ai giovani e alla società civile, non aveva mai rinunciato a seguire il dibattito politico italiano e cittadino e a deprecare argutamente le lacerazioni della sinistra e lo sfascio berlusconiano. Si sentiva ancora, in lui, lo spirito del giovane azionista e socialista, del maturo progressista e dell’eterno salveminiano.
Negli ultimi tempi, afflitto da un male inesorabile, Valente usciva di rado, per le cure e lo stretto indispensabile. Per questo non poté ritirare di persona il “Duomo d’argento”, che in extremis il Comitato scientifico del premio e la Pro Loco di Molfetta gli avevano assegnato. Il riconoscimento fu poi ritirato dalla figlia Tonia Valente.
Poiché non gradiva le visite improvvise, alcuni mesi fa, dopo qualche altro vano tentativo, gli telefonai per chiedergli se potevo portargli certe pubblicazioni. Mi rispose che per il momento non era possibile, ma che dopo qualche tempo mi avrebbe avvertito lui stesso, anche perché voleva parlarmi di questioni importanti.
Passarono diverse lunghissime settimane, ma la sua telefonata non arrivava. Ero combattuto tra il rispetto della sua volontà e il desiderio di salutarlo di persona. Poi, verso novembre, dopo aver incontrato Maria Valente, la sua seconda moglie, e averle rivelato il mio rammarico per non poterlo vedere, cercai di forzare la mano e telefonai di nuovo. Capii che era a letto. Mi disse che era in una situazione di «stallo» e non poteva ricevermi. Ne provai un sottile dolore, ma compresi che non voleva mostrarsi a un amico nel momento della sua maggiore precarietà. Prima di Natale gli inviai una breve lettera di auguri, «con l’affetto di sempre». So che la missiva gli giunse e che la lesse più volte, ma preferì il silenzio. Forse scelse di non rispondermi per non veder crollare le ultime difese del suo pudore all’incalzare dello sconforto, però di certo intuì il mio taciuto ma acuto dispiacere di non potergli essere vicino per un momento mentre si avvicinava all’arduo confronto con la morte.
Assistito dalla moglie Maria, Vincenzo Valente se n’è andato in una gelida giornata di fine gennaio. Ora è sceso il freddo nel cuore e sono rimasto più solo.
Marco Ignazio de Santis
Martedì, 31 gennaio 2006
